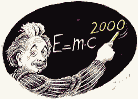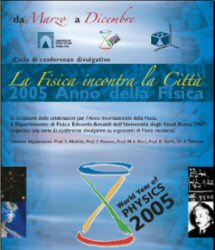Home Page
Finalita' dell'anno della fisica e della ricerca
Chi organizza
Assegnazione premi
Rappresentazioni Teatrali
La fisica incontra la citta'
MOSTRA:
E come Energia, E come Einstein
Master Classes
Inaugurazione Nuova Biblioteca del Dipartimento di Fisica Universita' "La Sapienza" e Premio Tomassoni-Chisesi
Inaugurazione Biblioteca OAR
Inaugurazione progetto divulgativo "La Strada del Tempo"
La misura del raggio della Terra (Esperienza di Eratostene)
Maggio della fisica:
Studio su "Vita Di Galileo" di Bertolt Brecht
Studio su "I fisici di Friedrich Durrenmatt
Fisica, teatro ed enogastronomia
Le vie dell'Astronomia a Roma
Eclissi solare 3 Ottobre 2005
Inaugurazione APENEXT
Concorso di Pittura
Physics for the 21st Century
Stampa:
Comunicati ufficiali
WYP2005 sulla stampa
Contatti
|
L'anno mirabile
Nel 1905, ormai tanti anni fa, di punto in bianco, lo spazio il tempo e la materia "non furono più quelli di una volta". La rinuncia, per l'uomo della strada, si faceva di botto assai pesante: ma anche per il filosofo, il letterato, il teologo, per tutti quelli, insomma, che di solito vanno a caccia di tranquillanti concettuali. Lo scatolone imbottito di etere entro il quale era conservato lo spazio immutabile svaniva, l'idea di un orologio universale buono per ogni viaggiatore andava in fumo, la vellutata uniformità dei fluidi continui si sgranava come un mucchio di fagioli atomici. Persino la luce si mutava in mazzetti di aghi colorati. Entrava in scena l'osservatore, a seconda che si movesse e rispetto a chi. Tutto acquistava una materialità insospettata ma mutevole con il moto, granulare ma corposa; un punto in moto rispetto a un altro (chi si muove, dei due?) vedeva lunghezze dilatate, tempi allungati, la sua stessa massa appariva gonfiata. La materia marcava luoghi eccezionali in vicinanza dei quali tempo e spazio si sarebbero addirittura incurvati, di lì a poco, come se ne avvertissero il peso. Bertrand Russell aveva scritto, ironicamente, che la fisica classica, di Newton, piaceva agli inglesi perché aveva la regolarità degli orari ferroviari; ora,con la crisi della simultaneità, andavano in crisi le coincidenze, i vagoni in viaggio si deformavano, i sedili si potevano sgretolare in pulviscoli indivisibili...
Era il "senso comune", il "realismo classico" che stava andando a farsi benedire: come scrisse più tardi McCormack, i fisici classici avrebbero provato incubi notturni. E così fu. Oggi la crisi è superata e le persone che rifiutano la relatività di Einstein o la meccanica quantistica appaiono, nell'ambiente scientifico, come "matti" senz'altro commento. Ma quei matti discendono da una moltitudine di illustri scettici o increduli, che meriterebbe di analizzare nel loro pensiero esitante di fronte al nuovo. Gli atomi apparivano assurdi ancora a Ostwald e Mach, dopo esserlo stati per Fourier; la relatività fu addirittura avversata come dottrina ebraica, incompatibile con la purezza del pensiero tedesco (di Stark, Lenard e molti altri). L'anno mirabile 1905 stava portando a un salto di qualità troppo grosso per il pensiero e la cultura degli uomini: le idee in grado di interpretare e ordinare lo studio del mondo in condizioni estreme (velocità confrontabili con quella della luce, dimensioni microscopiche come quelle di un atomo) non potevano più essere contenute nel linguaggio dell'esperienza comune, quel linguaggio che aveva consentito di esprimere con elementare chiarezza che la massa (la sostanza) dei corpi è indistruttibile, che la luce è fatta di onde che trasportano, come vibrazioni dell'etere, energia determinata dall'ampiezza di quelle vibrazioni (elettromagnetiche), che tutto è riconducibile a meccanica deterministica e la casualità non ha alcun ruolo in fisica. Il linguaggio che si impone attraverso l'anno mirabile è più matematico di quanto Galilei avrebbe osato supporre: una nuova generazione di specialisti stava per nascere, accanto agli sperimentatori, ai matematici e ai fisici matematici ibridi della tradizione ottocentesca: i fisici teorici. Alcune figure di transizione governeranno in modo ammirevole la transizione verso questi continenti ancora abitati da sole tribù di matematici isolati e scontrosi: in pieno '800, Hamilton con le sue idee sulla possibilità di unificare meccanica e ottica; poi Maxwell, Kirchoff, Wien, Boltzmann, Poincaré e, particolarmente, l'olandese Lorentz, per citare solo i più grandi. Ma intanto, la fisica aveva acquistato un ruolo di primissimo piano nella costruzione di rappresentazioni mentali di potenza senza precedenti, in grado di scavare negli angoli più riposti e remoti della realtà. Da quell'epoca in poi appena un momento nella storia dell'uomo oltre alle nuove chiavi di lettura del mondo nella sua estensione più vasta e completa, dagli atomi ai confini dell'universo, si fa strada una elaborazione di linguaggi senza precedenti che allo stesso tempo rende potentissima l'indagine e la recide dal inguaggio comune. Le tecnologie, che per secoli s'erano attestate sulle macchine semplici e che dalla fine del '700 avevano contribuito a creare e sfruttato il pensiero astratto della termodinamica per ideare motori efficienti, cominciarono a servirsi di ciò che era generalmente invisibile agli esseri viventi, campi, atomi, energie potenziali racchiuse nelle strutture materiali elementari: attraverso di esse, l'opinione pubblica aveva sentore del fatto che qualcuno avesse messo le mani su immense riserve di invenzioni future: era nata l'dea di progresso. Come in tutte le vicende umane, l'impatto sociale aveva generato interessi materiali, avidità e gelosia, concorrenza, perfino corruzione. I fisici cominciavano a mescolarsi con i politici, i militari, gli imprenditori e cominciavano anche, perciò, a subire i vizi tipici di questi ambienti. Non credo che tutte queste vicende negative possano attribuirsi alle aperture iniziate con l'anno mirabile; ma penso che una analisi obiettiva delle conseguenze indesiderate delle mirabilie di quell'anno sarebbe istruttiva. E però devo insistere sul fatto che è necessario sia obiettiva, perché molte analisi non obiettive sono state già fatte e hanno portato a integralismi pericolosi e insensati: un antiscientismo diffuso che mette la scienza alla radice di ogni male, un rifiuto pregiudiziale della razionalità e via discorrendo. Pensiamoci.
Editoriale di Carlo Bernardini
da Sapere dicembre 2004
|
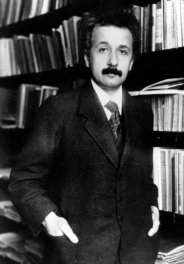
Einstein - 1905
|
 |
|